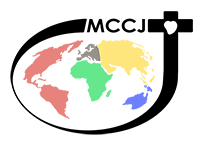Prima lettura (At 9,26-31)
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.
Il testo racconta l’arrivo a Gerusalemme di Paolo, dopo la conversione alla porta di Damasco e la difficoltà d’integrazione nella comunità. Da un lato Paolo “cercava di unirsi ai discepoli” per la singolare esperienza di conversione e l’approvazione nel predicare “apertamente nel nome del Signore”. Dall’altro lato, “tutti avevano paura di lui, non credevano che fosse un discepolo”, difficoltà più che comprensibile. Passare da persecutore a discepolo e, più ancora, a testimone della risurrezione nella comunità cristiana nascente non cosa di poco conto.
I discepoli si chiedono: la conversione è una tattica per meglio raggiungere l’obiettivo di persecuzione? O un fuoco di paglia, qualcosa di momentaneo, senza spessore e consistenza, e poi Paolo tornerà ad essere quello di prima? Insomma, sono molti i dubbi che, in circostanze come questa, motivano perplessità e sospetto.
Barnaba perora la causa di Paolo davanti agli apostoli e racconta loro che anche Paolo, durante il viaggio a Damasco, aveva visto il Signore e parlato. In Damasco “aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù”, caratteristica degli apostoli. In seguito all’intervento di Barnaba, Paolo entra a far parte della comunità di Gerusalemme, e “andava e veniva” nella città, mostrando lo stesso coraggio in Damasco nell’annunziare il nome del Signore.
Come Stefano, anche Paolo discute con gli ellenisti, i giudei di lingua greca (probabilmente greci convertiti al giudaismo). Quale sia il motivo per cui costoro sono ai ferri corti, al punto che “questi tentavano di ucciderlo”, il testo non lo dice. Molto probabilmente predica la salvezza che dipende dalla fede in Cristo e non dalla Legge mosaica, secondo uno dei temi centrali dei suoi scritti.
Si comprende lo sconcerto e la reazione dei destinatari nel percepire che non è servita a nulla la conversione dal paganesimo al giudaismo: di fatto la tensione è pericolosa, al punto che “i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso”.
Paolo non si scoraggia né si lamenta per il sospetto e la sfiducia della comunità nei suoi confronti; al contrario, in Gerusalemme, con coraggio e audacia predica esponendosi al rischio di perdere la propria vita, il che testimonia la solidità e la consistenza della conversione.
Paolo è timorato di Dio e dedicato alla causa di Dio. La scrupolosa osservanza della legge mosaica fa di lui un soggetto intollerante verso tutto ciò che deforma il cammino di salvezza, con predicazioni e proposte ritenute inopportune, se non false. È lo zelo con cui perseguitava, in un primo momento, i cristiani.
Lo stesso zelo lo caratterizza anche dopo la conversione alla porta di Damasco, nel rendersi conto della portata e del significato della morte e risurrezione di Cristo per lui e l’umanità. È la svolta radicale! In lui lo zelo prende ancor più consistenza e forza, al punto di rischiare, con grande coraggio e audacia, di perdere la propria vita.
La personalità fa di lui un apostolo di grande importanza. Lo dimostrano l’attività pastorale, gli scritti e la dedicazione alla causa di Cristo, che risaltano per audacia, coraggio, intelligenza creativa e innovativa nell’argomentare la portata e il significato del mistero pasquale.
Nel mezzo del singolare avvenimento, “la Chiesa era in pace (…) si consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero”. È un breve ed entusiastico riassunto della situazione della chiesa in Palestina. Anche se in realtà, fra le comunità, esistevano tensioni, incomprensioni e difficoltà di ogni genere, come lo stesso libro degli Atti registra.
Si tratta della crescita non solo quantitativa ma qualitativa. Il riferimento al timore del Signore e allo Spirito Santo induce a pensare non solo ad un maggior numero di aderenti ma, anche, alla migliore e profonda comprensione, degli effetti della morte e risurrezione di Gesù e dell’immersione nell’amore di Dio, presupposto necessario per vivere il comandamento dell’amore che il Maestro insegnò con la sua parola e azione.
È della qualità del rapporto, all’interno e fuori della comunità, che tratta la seconda lettura.
Seconda lettura (1Gv 3,18-24)
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
L’apostolo si rivolge alla comunità: “non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità”. Allora, come oggi, l’affermazione, pur essendo ampiamente accolta e condivisa, nella pratica non è correttamente assunta, inducendo molti a prendere gatto per lepre. Sono coloro che si ritengono dei buoni cristiani per la conoscenza della dottrina, per la partecipazione alla messa domenicale, alle pratiche devozionali e per la buona condotta personale, ma sono ben lontani dalla preoccupazione e dall’impegno per la crescita qualitativa dei rapporti sociali a ogni livello, in sintonia con l’avvento del regno di Dio e dei valori corrispondenti.
“In questo conosceremo che stiamo nella verità davanti a lui”, nell’agire e operare correttamente. La verità si fa, momento dopo momento, nella circostanza specifica. Essa non è riconducibile, semplicemente, alla sintonia dell’idea con l’oggetto o al principio di non contraddizione, ma all’azione o, meglio, all’insieme di parole e fatti che conformano il rapporto vicendevole nell’amore. Quest’ultimo non consiste nel fare quel che piace all’altro, ma ciò di cui ha bisogno (a volte è, addirittura, il contrario di quello che piace) per affermarsi come soggetti liberi per amare e nell’assumere, con determinazione e gioia, la causa del Regno.
In tal modo, “davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri”. Diversamente dalla nostra concezione attuale, al tempo di Paolo il cuore è la sede dell’intelligenza, del pensiero, del progetto, delle scelte opportune. Pertanto, procedere con rettitudine di pensiero e di azione – pur nei limiti di circostanze e fattori non percepiti a causa dei quali i quali non si è fatto di più e meglio – sarà motivo di rassicurazione davanti a Dio.
La rassicurazione si deve al fatto che “Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa”, e il pensiero e l’intelligenza umana e divina s’incontrano nella trasparenza del loro agire ed essere, in modo che quest’ultima rasserena la prima e la sprona a non soffermarsi sul rammarico, ma a compiere passi ulteriori di maggiore impegno e profondità. È quello che dice il Salmista: “l’anima mia ha sete del Dio vivente”, sete di crescere nella comunione con Lui.
La comunione e familiarità con Dio fa sì che “qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito”. Si tratta di chiedere sapienza, intelligenza, capacità e determinazione per compiere ciò che gli è gradito, per la collaborazione attiva e la causa del Regno. I comandamenti si sintetizzano nel ben noto “che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato” (Gv 12,15).
Praticare la verità nei rapporti interpersonali, nell’attiva e intelligente partecipazione alla vita familiare e sociale, nel prestare attenzione alle sfide globali dell’umanità pensando globalmente per agire localmente nel diritto e nella giustizia a favore dei marginalizzati, dei poveri, di chi vive in condizione disumana, di chi è escluso, è far risplendere la comunione con Dio, per la fede di Gesù Cristo assunta con consapevolezza e determinazione.
È anche il modo per rimanere in Dio e viceversa: “Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui”. Rimanere nella comunione vicendevole non è acquisizione definitiva per il battesimo e altri sacramenti, ma è frutto del farsi della verità nelle condizioni di cui sopra.
Fare la verità significa far sì che la forza della morte e risurrezione, attualizzata per la fede e celebrata nei sacramenti, produca il frutto che è lecito aspettarsi. La dinamica dell’amore alimenta il costante rinnovamento della persona e la rende capace di creatività audace nelle diverse circostanze e novità della vita.
È l’azione dello Spirito Santo nella persona e nell’istituzione, quando esse agiscono per amore. Lo Spirito Santo illumina la mente e imprime nel sentimento la certezza della presenza di Dio: “In questo conosciamo che egli – Dio – rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato”.
Il rimanere in Dio è condizione necessaria per produrre frutti in abbondanza, per una vita piena di soddisfazione, come indica il vangelo.
Vangelo (Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».
Il testo presenta la triangolarità agricoltore, vite e tralci. La finalità evidenzia le condizioni del tralcio (metafora del discepolo) affinché “porti più frutto” nel manifestare la gloria di Dio, la vita in abbondanza per gli uomini e la società rinnovata dalla pratica della giustizia e del diritto: “In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”.
Il discepolato è un processo interminabile, e consiste nell’entrare nella spirale dell’azione di Dio, che si espande sempre più per la dinamica dell’amore in tutto e tutti. Dio dirige, governa e conduce la storia all’ultimo e definitivo della comunione con lui; lo fa con la collaborazione di persone che crescono nel discepolato, coscienti e determinate per l’inserimento nella vite (l’insegnamento, la pratica della fede di Gesù) e l’avvento del Regno di Dio, del quale “il Padre mio è l’agricoltore”.
(Adattamento del testo di Alberto Maggi)
Gesù disse si suoi discepoli: “io sono la vite vera e il Padre mio l’agricoltore”. Allora ci sono dei ruoli ben distinti: Gesù è la vite, dove scorre la linfa vitale, il Padre è l’agricoltore. L’interesse dell’agricoltore è che la vigna porti sempre più frutto: “ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie”. L’evangelista sta parlando della comunità cristiana, dove c’è un amore che viene comunicato dal Signore, e questo amore si deve trasformare in amore dimostrato agli altri. E questo è caratteristico dell’Eucaristia: in essa si accoglie un Gesù che si fa pane, fonte di vita, per poi essere disposti a farsi pane, fonte di vita per gli altri.
Ci può essere il rischio che nella comunità ci sia una persona che assorba questa linfa vitale, assorba questa energia, assorba questo amore, assorba questo pane, ma poi non si faccia pane per gli altri, non trasformi l’amore che riceve in amore per gli altri. È un elemento passivo, che pensa soltanto al proprio interesse, a sé stesso, e quindi non comunica vita.
Ebbene, non gli altri tralci, e neanche Gesù, ma il Padre, prende e lo toglie, perché è un tralcio inutile. “Ma ogni tralcio che porta frutto”, cioè il tralcio che succhiando questa linfa vitale, ossia nell’Eucaristia, il tralcio che ricevendo Gesù come pane si fa poi pane per gli altri, porta frutto.
Dispiace vedere che, ancora, i traduttori rendono il termine con ‘potare’ che non è quello adoperato dall’evangelista. Il verbo adoperato da Giovanni è ‘purificare’, non ‘potare’. Sono due cose completamente diverse. Cosa significa purificare? Il Padre che ha a cuore che il tralcio porti più frutto sa individuare quegli elementi nocivi, quelle impurità, quei difetti che ci sono nel tralcio e lui provvede a eliminarli. Questo è importante: l’azione è del Padre; non deve essere il tralcio a centrarsi su sé stesso, ad individuare i propri difetti e cercare di eliminarli, perché centrandosi su sé stesso farà un danno irreversibile.
L’uomo si realizza non quando pensa a sé stesso, alla propria perfezione spirituale, che può essere tanto illusoria e lontana quanto è grande la propria ambizione; l’uomo deve centrarsi sul dono totale di sé, che è immediato. Allora, in ognuno di noi ci sono dei limiti, ci sono dei difetti, ci sono delle brutte tendenze. Ebbene noi non ci dobbiamo preoccupare perché sarà il Padre che, vedendo che questi limiti, questi difetti, queste tendenze sono di impedimento al portare più frutto, penserà ad eliminarli, non noi. Perché facendolo noi possiamo andare a toccare quelli che sono i fili portanti della nostra struttura e fare dei danni tremendi.
Allora “Il Padre lo purifica”. Questo dà piena serenità; l’unica preoccupazione del tralcio è portare frutto, e a tutti gli impedimenti a portare frutti abbondanti ci penserà il Padre, non gli altri tralci, neanche la vite, ma il Padre. Perché? “Perché porti più frutto”.
E dichiara Gesù “Voi siete già puri”. Ecco, vedete: quando i traduttori traducono il verbo con ‘potare’ anziché ‘purificare’, non rendono questo gioco di parole che l’evangelista fa tra il verbo ‘purificare’ e l’aggettivo ‘puri’. Quindi prima Gesù ha detto “Lo purifica”, e poi dice “voi siete già puri”. Perché? “A causa della parola che vi ho annunziato”. La parola di Gesù è un amore che si fa servizio. Ciò che purifica l’uomo non è il fatto che gli lava i piedi, ma la disponibilità poi di lavare a sua volta i piedi agli altri. Quindi questa parola, il messaggio di Gesù, si riferisce a un amore che si fa servizio e rende pura la persona.
Ebbene, l’amore che si traduce in servizio è la garanzia di essere in pieno contatto con il Signore. E Gesù ripete e dice: “Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me.” Quindi Gesù torna di nuovo a insistere sul fatto che questo amore da lui ricevuto si deve trasformare in amore comunicato, altrimenti si è inutili.
Ritorna Gesù a rivendicare il suo titolo, la condizione divina: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui”, (in questo processo dinamico di fusione di Dio, Dio chiede soltanto di essere accolto nella vita del credente, per dilatarne l’esistenza) “porta molto frutto”. Si dà la vita agli altri, e più si dà più si riceve. Si ha soltanto quel che si è donato: più il dono della vita agli altri è grande, illimitato, più la risposta di Dio sarà illimitata.
Poi Gesù avverte: “Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca”. Questa espressione l’abbiamo tradotta con ‘secca’, letteralmente ‘inaridisce’, indicando il popolo senza Spirito. Ebbene, chi non rimane in Gesù, chi ricevendo questo amore non lo comunica agli altri, si inaridisce, perché, ripeto, si possiede soltanto quello che si dona agli altri.
E poi, ecco la garanzia di Gesù che, purtroppo, noi nel linguaggio popolare abbiamo un po’ ridimensionato. Tutti quanti conosciamo l’espressione “Chiedete quello che volete e vi sarà dato”; però dimentichiamo le due condizioni che Gesù pone: – se rimanete in me, quindi se c’è questo amore da lui ricevuto che si trasforma in amore comunicato agli altri – se le mie parole rimangono in voi, quindi rimangono come indirizzo dell’orientamento della vita, dell’esistenza – un amore che si fa servizio per gli altri – a questo punto, solo a questo punto, e preceduto da queste due condizioni, Gesù dice “Chiedete quello che volete e vi sarà dato”.
Quindi, quando si vive in sintonia con il Signore, quando la vita dell’uomo si fonde con quella di Dio fino a diventare una sola cosa, l’unica cosa che si chiederà sarà il dono dello Spirito, una capacità ancora più grande d’amare. Perché al resto il Padre ci pensa. Il Padre non risponde ai bisogni e alle necessità dei suoi figli, ma li precede. Questo dà tanta sicurezza.
Ed ecco il finale: “In questo è glorificato il Padre mio”. C’era l’immagine che Dio dovesse essere glorificato attraverso opere straordinarie, magnificenze gloriose; no, l’unica maniera per manifestare la gloria di Dio, la rivelazione del suo amore, è un amore che gli assomiglia: “Che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli”. L’unica maniera per dar gloria a Dio è manifestare nella nostra vita un perdono, una misericordia, una condivisione che in qualche maniera gli assomiglino.