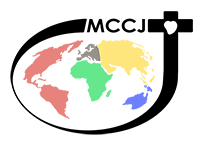Dopo 9 mesi abbondanti di combattimenti che hanno portato il Sudan sull’orlo dell’implosione, non si vedono ancora segnali che facciano pensare alla fine del conflitto in un prossimo futuro.
Anzi, gli avvenimenti degli ultimi giorni mostrano il complicarsi della situazione generale e in particolare l’inasprimento dei toni fra i due contendenti – il generale Abdel Fattah al-Burhan, capo della giunta militare che di fatto governa il paese, e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, conosciuto con il soprannome di Hemeti, comandante delle Forze di supporto rapido (RSF), le milizie associate al potere fino al momento dello scoppio del conflitto – e l’incapacità della diplomazia regionale e internazionale di trovare il bandolo per costringerli a trattare.
Si può considerare fallito anche l’ultimo tentativo: l’incontro dei capi di stato dei paesi dell’IGAD – Inter Governmental Agency for Development, l’organizzazione regionale cui generalmente l’Unione Africana delega la ricerca della soluzione delle crisi tra i paesi del Corno e dell’Africa orientale – convocato in seduta straordinaria lo scorso 18 gennaio ad Entebbe, in Uganda.
All’incontro erano presenti, tra gli altri, anche rappresentanti dell’Unione Africana, dell’ONU, dell’Unione Europea, di diversi paesi arabi e degli Stati Uniti. Un consesso completo e qualificato.
Per il Sudan, erano presenti Hemeti e l’ex primo ministro Abdallah Hamdok, ora coordinatore delle forze contrarie alla guerra, un coordinamento conosciuto come Takaddum (Sudanese Coordination of Civil Democratic Forces), che si propone di ripristinare un governo civile che riprenda la transizione democratica interrotta dal colpo di stato militare del 25 ottobre 2021 e poi dallo scoppio del conflitto, il 15 aprile 2023.
Aveva annunciato la sua assenza, invece, al-Burhan, per protestare contro la presenza del suo avversario, ritenuta un affronto per la sovranità del Sudan. Come se il suo governo, frutto di un golpe e mai riconosciuto internazionalmente, fosse da considerare effettivamente legittimo.
La frustrazione della diplomazia regionale e internazionale, emerge chiaramente dal comunicato ufficiale, diramato alla fine del summit, in cui si legge, tra l’altro, che l’assemblea “ribadisce il suo richiamo alle parti in conflitto di impegnarsi nel dialogo e nei negoziati” e “ricorda l’impegno … per un incontro faccia a faccia entro 14 giorni”.
Grida manzoniane, dimostratesi inefficaci fin dalle prime fasi del conflitto e definitivamente archiviate dalla decisione di al-Burhan di sospendere la partecipazione del Sudan all’IGAD, comunicata nei giorni immediatamente successivi all’incontro.
Analisti in allarme
Preoccupazioni per il più che probabile prolungarsi del conflitto vengono espresse da diversi analisti, in particolare da quelli sudanesi.
Suliman Baldo – fondatore e presidente dell’organizzazione Sudan Transparency and Policy Tracker (Segugio della trasparenza e della politica sudanese) esperto in giustizia, diritti umani e risoluzione dei conflitti in Africa, ex direttore dell’International Crisis Group per le questioni africane – nella sua ultima analisi, Sudan’s Interminable War, (L’interminabile guerra del Sudan) pubblicata nei giorni scorsi dall’International Centre for Dialogue Initiatives (Centro Internazionale per le iniziative di Dialogo) argomenta in particolare sulla proliferazione dei conflitti nel paese.
Dice che ormai sul terreno si evidenziano “numerosi scontri localizzati, connotati etnicamente, fuori dal controllo di entrambi le parti”, cioè l’esercito regolare (SAF) e le RSF. In una cartina esplicativa pubblicata dal sito di Radio Dabanga, vengono evidenziate le zone controllate dai diversi attori.
Oltre a quelle più estese dell’esercito (regioni settentrionali, orientali e parte di quelle centrali, colorate in rosso) e delle RSF (Darfur, Kordofan e gran parte di Khartoum, colorate in giallo) diverse altre aree del paese, colorate in verde, sono sotto il controllo di gruppi “ribelli”.
I più importanti sono l’SLA (Esercito per la liberazione del Sudan) di Abdel Waid al-Nur che ha le sue basi nel Jebel Marra in Darfur, e l’SPLM-N (Movimento popolare per la liberazione del Sudan-Nord) ala Abdel Aziz al-Hilu che ha le sue basi nei Monti Nuba, in Sud Kordofan, e agisce anche nello stato del Nilo Blu.
La conclusione è ovvia: nel caso che si arrivasse ad un accordo tra SAF e RSF, il ritorno della pace nel paese non sarebbe affatto scontato, anche perché il conflitto maggiore ha ridato fiato e motivazioni a quelli minori, che erano già presenti ma di fatto inattivi durante tutto il periodo della transizione democratica.
Baldo esprime giudizi impietosi sull’esercito nazionale e sulle RSF. Il primo si è rivelato inetto “dal momento che i comandanti in capo sono stati troppo impegnati in pratiche di grande corruzione per accorgersi della decadenza del SAF come forza combattente”.
Le RSF, invece, “sono allineate etnicamente (hanno le loro radici in Darfur, ndr) e hanno il saccheggio come motivazione maggiore dei suoi combattenti”. E dunque, se anche alla fine prevalessero sull’esercito, come sembra possibile, non sarebbero affatto accettate come forze rappresentative dell’intero paese.
Un’altra preoccupata analisi sul futuro del paese è stata diffusa nei giorni scorsi dal centro studi sudanese Fikra for Studies and Development. Autore il suo presidente, dr. Elshafie Khidir Saeed, noto esponente dell’opposizione al passato regime islamista di Omar El-Bashir, che ora sostiene l’esercito. Il testo – Four Conclusions about the War in Sudan (Quattro considerazioni sulla guerra in Sudan) – è piuttosto pessimista.
La prima considerazione dice che, in base a simili situazioni verificatesi nel passato “è molto improbabile che la guerra in Sudan non finisca presto”. I due contendenti, infatti non dimostrano nessuna volontà di negoziare e più passa il tempo, minori diventano le probabilità di arrivare ad una tregua permanente, mentre diminuisce il controllo centrale sulle rispettive truppe che possono originare conflitti locali.
Anche le forze della società civile, influenzate da forze esterne, tendono a diventare meno coese e dunque è minore la loro possibilità di influire su un eventuale processo di pace.
La seconda riguarda la comunità regionale ed internazionale. Secondo l’autore “sembra che i governi, sia a livello regionale che globale, abbiano un limitato interesse nel mettere fine velocemente e in modo sostenibile alla guerra in Sudan”.
Lo dimostra la continua fornitura di armi ai due contendenti e la corsa, neppure troppo mascherata, al controllo delle ingenti risorse del paese. Dall’attuale conflitto, il Sudan potrebbe uscire come un paese indebolito e frammentato, in preda al caos e dunque più facile da controllare manipolare dall’esterno.
La terza considerazione mette in luce la possibilità che il prolungarsi del conflitto sudanese ne inneschi uno regionale con implicazioni internazionali, a causa della posizione strategica del paese.
Non è un caso che da anni diversi paesi siano in competizione per aprire basi militari sulla costa sudanese del Mar Rosso che proprio in questi giorni si dimostra uno dei punti caldi della stabilità globale.
Infine, un paese nel caos diventa un terreno fertile per la nascita e il consolidarsi di organizzazioni terroristiche transnazionali. Questa circostanza è tanto più probabile in un paese impoverito, dove la popolazione e ospitata in campi profughi e dipende dai sempre più scarsi aiuti umanitari.
Insomma, gli analisti sudanesi non si nascondono i pericoli per il futuro del loro paese. Ma la loro lucidità “non vuole suggerire la resa, dal momento che questa non è un’opzione per il popolo sudanese. Piuttosto, dovrebbe servire come potente sorgente di ispirazione e motivazione per la società civile sudanese perché presenti una sua visione forte che porti alla fine della guerra”.
Ѐ la conclusione dell’analisi di Elshafie Khidir Saeed, un auspicio che, per ora, non sembra vicino a realizzarsi.
Bruna Sironi – Nigrizia