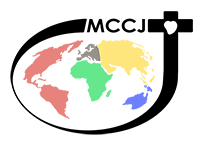P. Gian Paolo Bandera se n’è andato venerdì scorso, in sordina, come era vissuto in sordina, soprattutto negli ultimi anni, quasi 90. Una vita lunga, ricca, significativa come direbbero certamente i molti che l’hanno conosciuto, ammirato e gli hanno voluto bene.
In occasioni come questa io varie volte ho fatto una constatazione. Quanto più una persona accumula anni di vita, tanto meno si riesce a parlarne. Di un giovane, morto prematuramente, si dicono mille cose, si riesce addirittura a intravedere quello avrebbe potuto realizzare e che non ha fatto. Per un anziano è diverso. Tutta la vita di solito è lì e ci si accorge che l’essenziale è poco. L’ho sempre trovato un segno di freddezza e di superficialità. Devo dire che comincio a rivedere questo concetto, soprattutto se applicato alla vita di un missionario. Forse è il più grande elogio il dire che quella vita è rimasta con la gente, come semente rimasta per strada e che porta frutto da qualche parte, certamente, solo Dio sa dove. Credo che valga per P. Paolo: un uomo morto in sordina, vissuto in sordina, ma non per questo una vita insignificante.
L’ho conosciuto in Brasile, il paese dove ha passato circa 40 anni di vita. In alcuni momenti ho condiviso con lui attività e vita comunitaria.
Chi scorre superficialmente la sua vita, può avere l’impressione di un uomo eternamente insoddisfatto. Basta ripercorrere le tappe della sua vita:
Nato nel 1922, è stato ordinato nel 1948, a 26 anni.
I primi 13 anni li ha passati in Italia. In Brasile ci è arrivato nel 1962, quando quella provincia stava investendo molto, soprattutto per pressione e convinzione personale dell’allora provinciale P. Rino Carlesi, nella formazione dei giovani e nei seminari. Nello stato dello Spirito Santo, una zona di immigrazione italiana, si vedeva il posto ideale per lanciare la semente della vocazione missionaria. P. Paolo sembrava l’uomo giusto. Per la sua profondità e la sua intensa vita spirituale, era l’esempio del padre spirituale che sembrava indispensabile a strutture di quel tipo. Difatti, dopo un anno di conoscenza della realtà brasiliana a Conceição da Barra, nord dello stato, fu mandato nel 1963 al seminario di Ibiraçu, appena costruito. Tutto era agli inizi. Il seminario stava aprendo le sue porte (fu inaugurato ufficialmente nel 1964). Molte attese, molte speranze, fu preparata una visita speciale del superiore generale P. Todesco. Molto entusiasmo attorno a quel progetto. Paolo invece si accorse subito che qualcosa non andava. Difatti vi rimase solo un anno. Non era il suo ambiente. Non si trovava a suo agio. Un ambiente troppo strutturato, con una formazione troppo europea in un ambiente che di europeo aveva poco anche se i discendenti erano europei. Chiese di andarsene. Venne allora mandato a una parrocchia di quello stesso stato, Mantenópolis, una zona difficile ma con un lavoro tradizionale, di poca evangelizzazione e molta sacramentalizzazione. Vi rimase con molta fatica per 3 anni, dal 1964 al 1967. Nel 1968 lo troviamo a Gerônimo Monteiro, in un altro seminario che stava aprendo le sue porte e che riproduceva le difficoltà di Ibiraçu. Stesse problematiche, stesse reazioni personali. Poi dal 1969 al 1971 a Sao José do Rio Preto, in un altro seminario, il quarta che P. Carlesi aveva progettato in pochi anni. Carlesi riteneva che questa fosse la strada per consolidare la presenza comboniana in Brasile. La storia dimostrò che aveva sbagliato e P. Paolo lo sentiva nelle sue reazioni emotive. Dal 1972 al 1976 trovò rifugio a Rio de Janeiro, nelle dipendenze di un collegio di suore, al quale serviva come assistente spirituale e del quale si serviva per accogliere amici e familiari di comboniani che venivano a trovare i loro figli o parenti. Ma nemmeno là si trovò a suo agio. Dal 1977 al 1978 lo ritroviamo a Gerônimo Monteiro; 1979-1980 ad Água Doce; dal 1981 al 1983 a Brasília; dall’84 all’87 a São Paolo; 1987-1988: ancora Brasília; 1990-1991: in Curia, a Roma; 1992-1993: São José do Rio Preto; 1994-1995: ancora in Italia; 1996: São Mateus, poi ancora a Brasília; 1997: Belo Horizonte; 1998: Lages; 1999: Porto Velho; 2000: Curitiba; 2001-2002: Pedro Canário; 2003-2004 São Paolo e poi, dal 2004 in Italia.
Questo è stato P. Paolo. Un uomo di una grandissima umanità, di una grande ricchezza spirituale, ma anche un uomo inquieto. I suoi numerosi spostamenti lo confermano. I colleghi lo sapevano che aveva queste difficoltà, ma lo accoglievano sempre volentieri perché mai creava problemi in comunità. Ma era alla ricerca di qualcosa che non riusciva a trovare e che spesso lo faceva entrare in crisi. In comunità era attentissimo. Gli piaceva essere responsabile della logistica o di qualche servizio in casa. Andava volentieri a fare le spese, gli piaceva andare al mercato, si accupava del cibo, delle pulizie. Lo faceva con una dedizione esemplare. Voleva sempre che le cose fossero a posto, le stanze in ordinde, la cappella curata, la cucina rifornita. Ci teneva che il cibo fosse preparato con cura. Quando toccava a lui occuparsi del pranzo, lo faceva prima, con anticipo, mai all’ultimo momento, proprio perché non si dovesse improvvisare. La pizza doveva avere i suoi ingredienti, che poi erano quelle piccole cose che servivano a dimostrare che c’era un tocco speciale e per lui una maniera di dire che voleva bene ai confratelli. Non che gli piacesse mangiar bene, anzi alle volte spariva dopo aver preparato il pranzo agli altri, ma lo faceva perché riteneva che la cura della casa, del cibo, delle piccole cose erano modi concreti di creare comunità. Difatti le cose che lo spiazzavano e lo facevano andare in crisi non erano le grandi scelte missionarie o le sfide della realtà. Lo disturbavano visibilmente la superficialità dei rapporti e aoprattutto la trascuratezza, la mancanza di comunicazione che impediva che, per esempio, un ospite fosse accolto con attenzione come, secondo lui, si doveva fare con ogni persona ch viene nelle nostre case. Ricordo alcune volte che mi manifestò esattamente questo. La sofferenza personale a causa degli sgarbi e della grossolaneria comunitaria. Reagiva rinchiudendosi su se stesso, facendosi da parte, fino a dire, a un certo punto, “so però che il problema sono io, e per questo mi faccio da parte, perché le persone possano vivere come credono”. Ha girato e rigirato le comunità della provincia cercando umanità e sempre trovando motivi per andarsene. Oggi direi che Paolo ha sofferto molto a causa della poca qualità della nostra vita comunitaria. Lui sapeva che non serve niente pregare insieme se poi non si vive da fratelli.
Di formazione era anteriore al Vaticano II, ma fu uno che mai si sentì a disagio nelle scelte anche forti che si fecero in Brasile dopo il Vaticano II, nella linea dei ministeri, delle comunità di base e della teologia della liberazione. Pur non essendo mai stato un uomo di punta, P. Paolo fu nel gruppo tra i più aperti e lo riconoscevano anche quelli che spingevano di più verso il rinnovamento. Paolo era un uomo onesto e corretto. Non faceva il moralista, non gli piaceva rifugiarsi nelle certezze del passato, né, tantomeno, ripetere la dottrina solo perché lo sembrava chiedere la gerarchia. Discuteva, non aveva paura di affrontare anche i temi più scottanti della missione e della vita cristiana, ma alla fine ci si accorgeva che nei suoi ragionamenti quello che lo guidava era una grandissima umanità e un enorme buon senso.
La gente apprezzava la sua semplicità e generosità. E anche la qualità del suo servizio pastorale. Mai improvvisava un’omelia o una celebrazione. Se le scriveva, anche se le doveva fare per le due o tre persone della comunità. Si vedeva che dietro le sue riflessioni c’era il saggio del vangelo: quello che andava sempre nel baule della vita per cercare i tesori più veri, quelli che resistono al tempo e alle intemperie della storia.
Furono queste sue caratteristiche che lo resero un uomo apprezzato e amato da tutti. Quando cominciò a non ascoltare, si fece da parte più di prima. Visse questo problema con profondo disagio. Sapeva di non riuscire più a seguire una discussione. Chiedeva che non lo obbligassero a partecipare alle riunioni, soprattutto nelle comunità, con la gente. Accettava qualsiasi altro servizio, ma non questo perché non capiva e non aveva il coraggio di chiedere che parlassero a voce alta o ripetessero le cose che gli sfuggivano. Si faceva da parte, certamente per evitare di diventare un peso per gli altri. Cominciò a stare a suo agio tra i libri, in casa, nelle faccende domestiche, nelle biblioteche, negli archivi, e fu dove passò alcuni degli ultimi anni della sua vita, mettendo insieme documenti, aiutando a organizzare i servizi burocratici, magari solo per facilitare il lavoro di chi dipendeva da quelle carte. Poi anche la vista si indebolì e fu quando si sentì a suo agio nel magazzino delle medicine che arrivavano a questa casa madre di Verona. Era quello che riusciva a fare. Ci metteva tutto se stesso. Lo faceva con amore e dedizione, come se fosse il suo lavoro del quale era responsabile.
L’ho visto per l’ultima volta pochi giorni fa, passando per questa casa. Mi fece un largo sorriso. Non immaginavo che sarebbe stato il suo addio.
A me, ma credo che altri potrebbero dire lo stesso in questo momento, ha voluto bene. Ogni tanto mi mandava un biglietto con gli auguri di Natale o di compleanno. Non dimenticava. Le persone erano per lui un dono grande e lo coltivava, a modo suo. Era contento quando qualcuno se ne accorgeva.
Io ringrazio veramente il Signore di averlo messo sulla mia strada. P. Paolo non è stato di quei missionari che hanno fatto storia nell’istituto ma è stato tra i servi fedeli, che hanno vissuto perché anche nella missione mai avessimo a perdere l’umanità.
Lo affidiamo ora al Signore, chiedendogli che lo faccia riposare dalle sue fatiche e dalle sue inquietudini.
P. Giovanni Munari